Una particolare forma del virus del Vaiolo, utilizzato come vaccino, rappresenta una nuova speranza per la cura di numerose tipologie di cancro. Recenti ricerche di laboratorio hanno dimostrato l’efficacia del vaccino del vaiolo nel mantenere sotto controllo un tipo di carcinoma letale per i tessuti del fegato.
 Da una decina di anni, scienziati e ricercatori selezionano geneticamente alcuni virus in grado di individuare e distruggere le cellule tumorali in modo altamente selettivo. Sulla scia del successo ottenuto da un gruppo di ricercatori cinesi con il virus ONYX-015, il virologo Stephen Thorne della University of Pittsburgh (Pennsylvania – USA) ha avviato l’innovativo studio sul virus del vaiolo.
Da una decina di anni, scienziati e ricercatori selezionano geneticamente alcuni virus in grado di individuare e distruggere le cellule tumorali in modo altamente selettivo. Sulla scia del successo ottenuto da un gruppo di ricercatori cinesi con il virus ONYX-015, il virologo Stephen Thorne della University of Pittsburgh (Pennsylvania – USA) ha avviato l’innovativo studio sul virus del vaiolo.
Sotto la sua attenta guida, un team di ricercatori ha rimosso una coppia di geni dal vaccino di un virus, indispensabili per la crescita di quest’ultimo all’interno delle cellule. In questo modo il virus può crescere solamente nelle cellule tumorali in cui è stato iniettato, senza contagiare le cellule sane. Oltre a rimuovere una coppia di geni, i ricercatori hanno provveduto a inserire nuove istruzioni genetiche all’interno del virus. Questo gene aggiuntivo è in grado di stimolare una violenta reazione del sistema immunitario, che riconosce e attacca le cellule tumorali infettate con il virus.
![Tumore al fegato prima e dopo il trattamento con il vaccino modificato del virus del vaiolo. In quattro settimane la massa tumorale è diminuita a meno della metà [credit: Stephen Thorne/University of Pittsburgh | via Science]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/2007102611.thumbnail.jpg?w=525) I risultati, a dir poco sorprendenti, ottenuti in laboratorio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Clinical Investigation, destando molto interesse nella comunità scientifica.
I risultati, a dir poco sorprendenti, ottenuti in laboratorio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Clinical Investigation, destando molto interesse nella comunità scientifica.
Le cellule tumorali potrebbero essere eliminate completamente dagli organismi utilizzando dosi controllate del virus combinate alle procedure farmacologiche già in uso. Ottenuto il via libera dalla Food and Drug Administration, il prof. Thorne potrà iniziare entro pochi mesi le prime sperimentazioni cliniche su un cospicuo numero di volontari. Dimostrare la sicurezza del trattamento sarà infatti il primo passo necessario per proseguire la ricerca. I test di laboratorio hanno dimostrato come il vaccino del vaiolo non comporti alcun rischio per le cellule sane, ma per precauzione si pensa di ricorrere ugualmente all’utilizzo di immunizzanti per arginare eventuali reazioni al virus.
Quello che per secoli è stato un vero incubo per l’uomo, con decine di milioni di decessi, potrebbe ora trasformarsi in una nuova àncora di salvezza per l’epidemia del nuovo millennio.
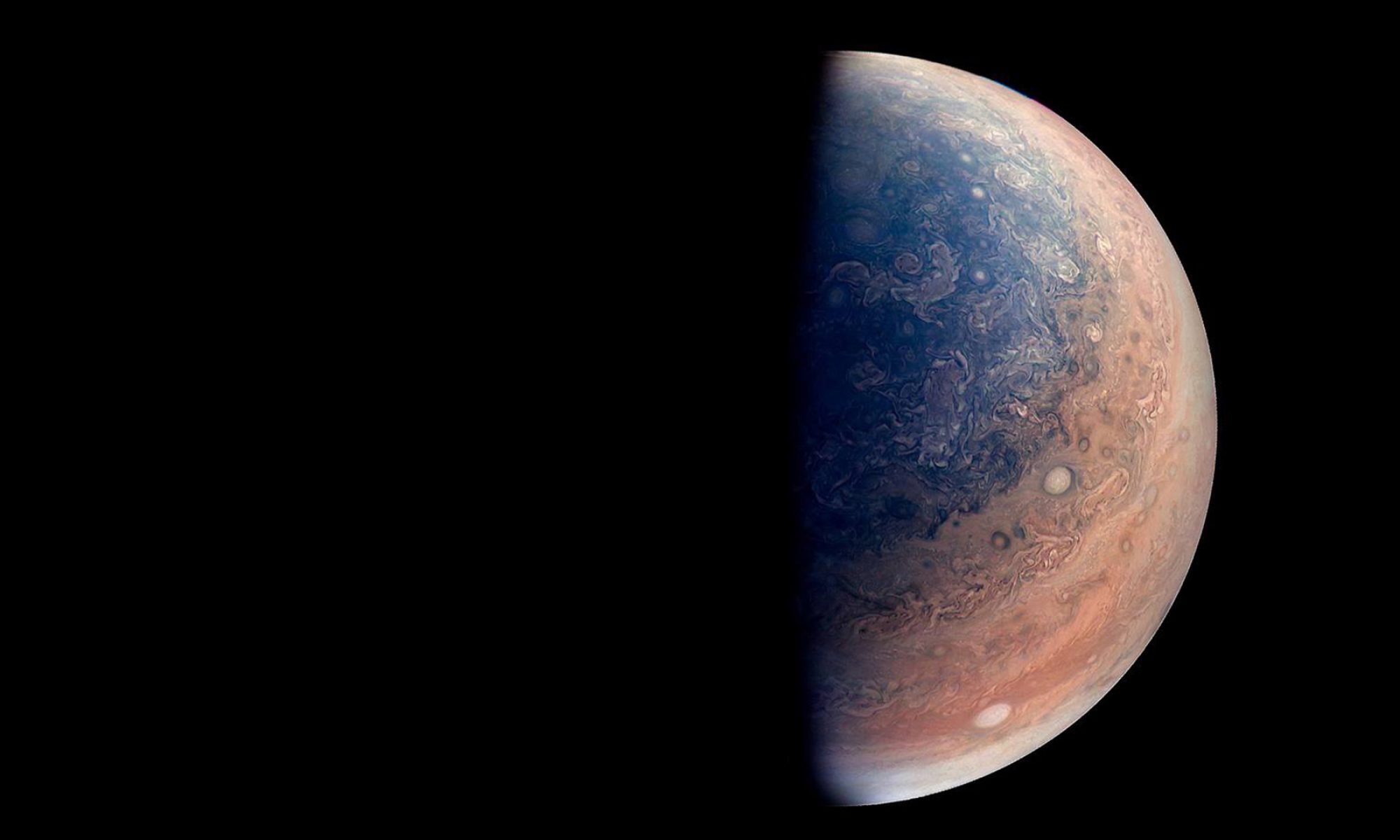
![Struttura chimica del glicogeno, segmento [credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/glicogeno.thumbnail.jpg?w=525)
![“Noduli” neuronali causati dalla malattia di Lafora [credit: Louis Requena, M.D.]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/10_01219.thumbnail.jpg?w=525)



![Neuroni sani a confronto con neuroni danneggiati dal morbo di Alzheimer [photo credit: GHI]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/alzheimernerve.thumbnail.jpg?w=525)
![Schema della struttura dell’orecchio interno [photo credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/orecchiointerno.thumbnail.jpg?resize=98%2C88)
![Spaccato dell’apparato cocleare [photo credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/coclea.thumbnail.jpg?w=525)
 Un gruppo di ricercatori guidati da Matt Davis, del Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unity (Cambridge, UK), ha studiato le reazioni di 12 volontari sotto l’effetto di un particolare anestetico, il Propofol, in grado di indurre differenti livelli di sonnolenza a seconda delle dosi somministrate.
Un gruppo di ricercatori guidati da Matt Davis, del Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unity (Cambridge, UK), ha studiato le reazioni di 12 volontari sotto l’effetto di un particolare anestetico, il Propofol, in grado di indurre differenti livelli di sonnolenza a seconda delle dosi somministrate.![Attività cerebrali registrate in un volontario cosciente e poi sedato [photo credit: MRC]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/cervellodormire.thumbnail.jpg?w=525)