Una ricerca condotta su alcuni pazienti affetti da Alzheimer ha rilevato l’esistenza di alcune specifiche proteine nel sangue che potrebbero essere utilizzate per diagnosticare il “morbo dell’oblio” in maniera precoce ed efficace.
L’unico metodo finora utilizzato dai medici per diagnosticare l’Alzheimer prevede una serie di analisi mirate ad escludere altre possibili patologie. A oggi, infatti, non esiste un test definitivo per questa terribile malattia, se non l’analisi post mortem dei tessuti cerebrali e dei marcatori del morbo.
 Dopo numerosi anni di studio, il neurologo Tony Wyss-Coray (Stanford University School of Medicine in California) ha recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine i sorprendenti risultati delle sue ricerche sui biomarcatori dell’Alzheimer, la “firma” del morbo riscontrabile negli individui affetti dalla malattia.
Dopo numerosi anni di studio, il neurologo Tony Wyss-Coray (Stanford University School of Medicine in California) ha recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine i sorprendenti risultati delle sue ricerche sui biomarcatori dell’Alzheimer, la “firma” del morbo riscontrabile negli individui affetti dalla malattia.
Grazie all’impegno del suo gruppo di ricercatori, Wyss-Coray ha identificato una combinazione particolare di 18 proteine in grado di indicare la presenza – anche nei primissimi stadi – del morbo di Alzheimer. Se i prossimi test confermeranno l’importante scoperta, sarà possibile diagnosticare la malattia con un banalissimo esame del sangue. Le persone positive al test potrebbero così iniziare da subito le terapie, oggi sempre più mirate, tese a rallentare i devastanti effetti dell’Alzheimer.
![Neuroni sani a confronto con neuroni danneggiati dal morbo di Alzheimer [photo credit: GHI]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/alzheimernerve.thumbnail.jpg?w=525) Per raggiungere questo promettente risultato, i ricercatori guidati da Wyss-Coray hanno esaminato le proteine presenti in 259 campioni di sangue, provenienti da individui affetti o meno dalla malattia. Il team di ricerca ha poi focalizzato la propria attenzione sulle 120 proteine maggiormente utilizzate dalle cellule per comunicare tra loro, e su un gruppo di 18 aggregati proteici rinominato communicode. “Abbiamo pensato che queste proteine, presenti nel sangue, potessero portare qualche traccia dal cervello sulla presenza o meno della malattia” ha dichiarato un entusiasta Wyss-Coray.
Per raggiungere questo promettente risultato, i ricercatori guidati da Wyss-Coray hanno esaminato le proteine presenti in 259 campioni di sangue, provenienti da individui affetti o meno dalla malattia. Il team di ricerca ha poi focalizzato la propria attenzione sulle 120 proteine maggiormente utilizzate dalle cellule per comunicare tra loro, e su un gruppo di 18 aggregati proteici rinominato communicode. “Abbiamo pensato che queste proteine, presenti nel sangue, potessero portare qualche traccia dal cervello sulla presenza o meno della malattia” ha dichiarato un entusiasta Wyss-Coray.
I ricercatori hanno notato che un set di 18 proteine “addette alle comunicazioni” si presentavano con livelli di concentrazione molto differenti tra gli individui affetti da Alzheimer e tra quelli sani. Comparando i risultati dei test effettuati su 20 pazienti, cui era già stato diagnosticato il morbo, il team di ricerca ha dimostrato come la forte concentrazione del set di 18 proteine sia un indicatore molto affidabile per rilevare la presenza dell’Alzheimer.
La scoperta di Wyss-Coray potrebbe condurre presto a un nuovo test per verificare, in maniera molto più affidabile e diretta, la presenza dell’Alzheimer. La diagnosi precoce del morbo è fondamentale per arginare da subito i suoi effetti devastanti.
Nonostante ad oggi non esista una cura definitiva per il morbo, i numerosi protocolli terapeutici affinati in questi ultimi anni consentono di rallentare drasticamente la corsa dell’Alzheimer che porta chi ne è affetto a un inesorabile oblio.
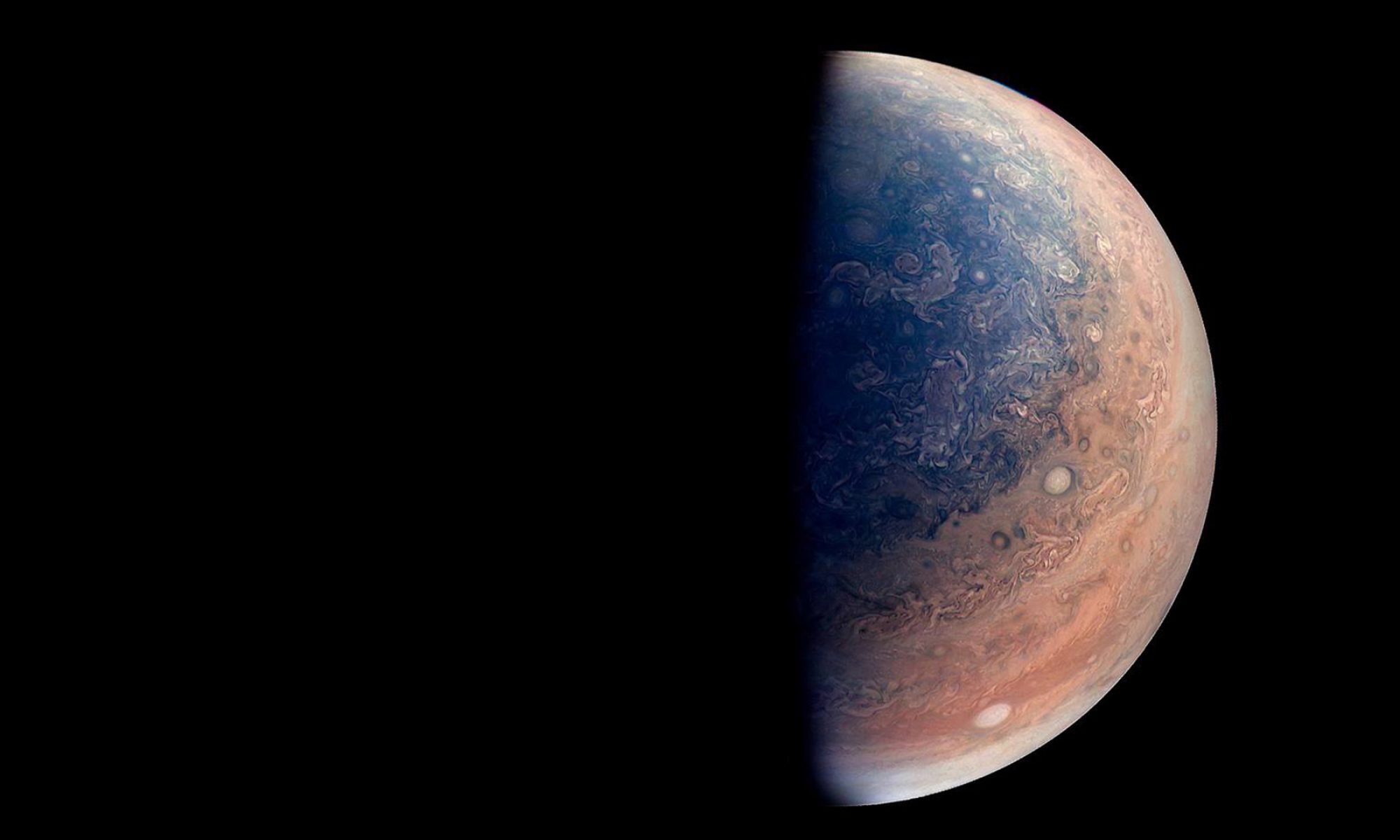
![Schema della struttura dell’orecchio interno [photo credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/orecchiointerno.thumbnail.jpg?resize=98%2C88)
![Spaccato dell’apparato cocleare [photo credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/coclea.thumbnail.jpg?w=525)
 Secondo una recente ricerca, la varietà più diffusa e coltivata di mais geneticamente modificato potrebbe compromettere seriamente l’equilibrio degli ecosistemi acquatici.
Secondo una recente ricerca, la varietà più diffusa e coltivata di mais geneticamente modificato potrebbe compromettere seriamente l’equilibrio degli ecosistemi acquatici.
 Un gruppo di ricercatori guidati da Matt Davis, del Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unity (Cambridge, UK), ha studiato le reazioni di 12 volontari sotto l’effetto di un particolare anestetico, il Propofol, in grado di indurre differenti livelli di sonnolenza a seconda delle dosi somministrate.
Un gruppo di ricercatori guidati da Matt Davis, del Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unity (Cambridge, UK), ha studiato le reazioni di 12 volontari sotto l’effetto di un particolare anestetico, il Propofol, in grado di indurre differenti livelli di sonnolenza a seconda delle dosi somministrate.![Attività cerebrali registrate in un volontario cosciente e poi sedato [photo credit: MRC]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/cervellodormire.thumbnail.jpg?w=525)
![Modello molecolare dell’anidride carbonica [photo credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/10/co2.thumbnail.jpg?w=525)
 Partendo da questa ipotesi, lo psichiatra Eric Griez della
Partendo da questa ipotesi, lo psichiatra Eric Griez della 
