 Additato come il primo responsabile dei profondi cambiamenti climatici che iniziano a verificarsi nel nostro Pianeta, il genere umano non gode di moltissima stima nella biosfera. Ma cosa accadrebbe se di colpo gli oltre sei miliardi di esseri umani che popolano la Terra scomparissero improvvisamente? Come reagirebbe il Pianeta Azzurro, e cosa resterebbe a testimoniare le nostre esistenze?
Additato come il primo responsabile dei profondi cambiamenti climatici che iniziano a verificarsi nel nostro Pianeta, il genere umano non gode di moltissima stima nella biosfera. Ma cosa accadrebbe se di colpo gli oltre sei miliardi di esseri umani che popolano la Terra scomparissero improvvisamente? Come reagirebbe il Pianeta Azzurro, e cosa resterebbe a testimoniare le nostre esistenze?
Il pluripremiato giornalista americano Alan Weisman ha cercato di rispondere a queste domande, compiendo una piccola rivoluzione copernicana nello studio dei cambiamenti planetari: capire cosa ne sarebbe della Terra se di colpo noi tutti smettessimo di aggredirne le risorse. La sua approfondita e documentata ricerca è confluita in The World Without Us (Il Mondo senza di noi), libro fresco di pubblicazione negli States, in cui Weisman ipotizza in una metodica linea del tempo, l’evoluzione della Terra senza il genere umano.
Ecco la sua corsa nel tempo dall’oggi a un futuro di cinque miliardi di anni.
2 giorni dalla scomparsa del genere umano
Primo effetto, banale ma non così scontato, la metropolitana di New York sarebbe invasa dall’Oceano a causa del mancato pompaggio delle acque.
7 giorni
A causa del mancato rifornimento di carburante, la maggior parte dei generatori di emergenza delle centrali nucleari si arresterebbe, causando la fusione del nocciolo nei reattori.
1 anno
In tutto il mondo un miliardo di uccelli, uccisi ogni anno, sopravvivrebbe grazie al mancato funzionamento delle luci nei grattacieli, dei ripetitori, delle pale per l’energia eolica e dei cavi dell’alta tensione.
Molte specie animali inizierebbero a ripopolare i siti ove si erano verificate le esplosioni delle centrali nucleari.
3 anni
La mancata manutenzione delle tubature del gas porterebbe a violente esplosioni nelle città, con considerevoli conseguenze sulla stabilità degli edifici. Nelle zone climatiche più fredde, l’acqua congelerebbe dilaniando le tubature che la contenevano. Non potendo contare su caldi rifugi in cui passare l’inverno, persino gli scarafaggi sarebbero costretti a traslocare…
20 anni
Abbandonato alle forze della Natura, il canale di Panama scomparirebbe completamente, riunificando dopo decenni le due Americhe. Intanto, nelle metropoli devastate per anni da incendi, inondazioni ed esplosioni, la vegetazione inizierebbe ad invadere e colonizzare ciò che l’uomo aveva creato.
Un secolo
Il mancato commercio di avorio consentirebbe all’intera popolazione di elefanti del globo di aumentare di almeno 20 volte.
Le specie di piccoli predatori come volpi, donnole, orsetti lavatori e tassi verrebbero sterminate dai discendenti di animali molto combattivi allevati fino a un secolo prima dall’uomo: i gatti domestici.
Acceleriamo e compiamo un balzo di…
Cinque millenni
Tutte le infrastrutture create dall’uomo sarebbero ormai completamente distrutte, compresi i ponti e gli edifici in acciaio più resistenti. Tra i pochi reperti della nostra civiltà l’unico in grado di sopravvivere potrebbe essere il Tunnel sotto la Manica.
100.000 anni
I livelli di anidride carbonica si riporterebbero sui valori esistenti prima della comparsa dell’Uomo sul pianeta.
10 milioni di anni
Qualcosa a testimonianza della nostra esistenza sopravvivrebbe ancora: alcune parti dei monumenti in bronzo che oggi ornano le nostre città.
Tra i 4 e i 5 miliardi di anni
La Terra inizierebbe a soffrire la progressiva espansione della stella che un tempo le aveva dato la vita: il Sole. Intorno ai 5 miliardi di anni per il nostro Pianeta sarebbe la fine, completamente bruciato e inglobato dall’incredibile energia sprigionata dal Sole, alle prese con le sue ultime drammatiche fasi di vita.
Secondo gli scienziati consultati da Weisman una sola cosa creata dall’uomo potrebbe sopravvivere a tutto questo: le onde radio. Quotidianamente emesse per le nostre comunicazioni, le onde radio continuano per miliardi di anni luce il loro cammino verso l’ignoto, portando con sé la testimonianza della nostra esistenza.
Chissà, magari quando la Terra sarà ormai un ricordo, qualcuno lassù capterà un semplice messaggio: “13 ottobre 2007, continua l’allarme per il surriscaldamento globale. Occorre agire subito…”
[pubblicato per la prima volta da me su CattivaMaestra]
 Ogni anno, nella parte sud-orientale della Groenlandia, i ghiacciai danno origine a una enorme massa di iceberg pari a un cubo di 6,5km³. Ciò comporta una sensibile diminuzione dei ghiacciai dell’entroterra, che non riescono a ripristinare le ingenti quantità di ghiaccio portate via dal rapido disgelo.
Ogni anno, nella parte sud-orientale della Groenlandia, i ghiacciai danno origine a una enorme massa di iceberg pari a un cubo di 6,5km³. Ciò comporta una sensibile diminuzione dei ghiacciai dell’entroterra, che non riescono a ripristinare le ingenti quantità di ghiaccio portate via dal rapido disgelo.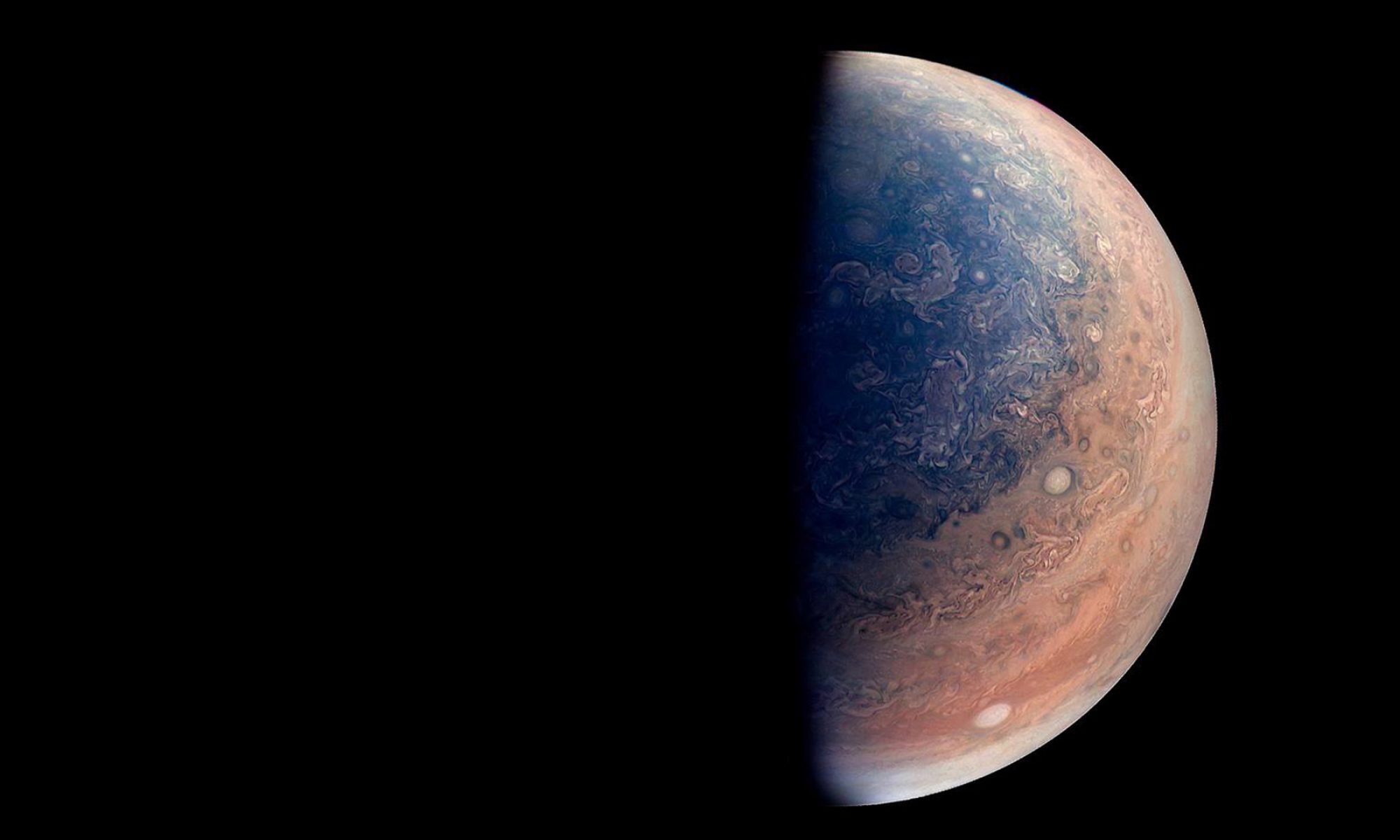



![Schema del ciclo di emissione e assorbimento di CO2 degli oceani [photo credit: Planktos.com]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/09/co2oceano.thumbnail.jpg?w=525)
![Sommità di un “pozzo di pompaggio oceanico” [photo credit: Atmocean]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/09/atmo.thumbnail.gif?w=525)
 Alcuni scienziati temono infatti che il bilancio finale del processo proposto da Lovelock e Rapley possa essere negativo.
Alcuni scienziati temono infatti che il bilancio finale del processo proposto da Lovelock e Rapley possa essere negativo.

![Rappresentazione grafica dell’interno della Terra [credit: Wikipedia]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/09/crosta_mantello_nucleo.thumbnail.png?w=525)

