I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology sono riusciti nella difficile impresa di comprendere come due mutazioni del virus H1N1, dell’influenza aviaria, siano state fondamentali nella diffusione della malattia tra gli esseri umani, che causò nel corso del 1918 circa 50 milioni di vittime.
 Il gruppo di ricerca ha dimostrato come l’influenza del 1918 sviluppò due mutazioni sulla superficie di una molecola nota come emoagglutinina (HA), che permisero al virus di attecchire con molta più facilità nelle vie respiratorie superiori dell’organismo umano. L’importante scoperta, che potrebbe fornire informazioni per lo studio dei nuovi virus dell’influenza aviaria, è stata effettuata al MIT dal team guidato dal prof. Ram Sasisekharan, che ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Il gruppo di ricerca ha dimostrato come l’influenza del 1918 sviluppò due mutazioni sulla superficie di una molecola nota come emoagglutinina (HA), che permisero al virus di attecchire con molta più facilità nelle vie respiratorie superiori dell’organismo umano. L’importante scoperta, che potrebbe fornire informazioni per lo studio dei nuovi virus dell’influenza aviaria, è stata effettuata al MIT dal team guidato dal prof. Ram Sasisekharan, che ha pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Come dimostrò Sasisekharan in uno studio precedente, i virus dell’influenza possono fare breccia nelle cellule dell’apparato respiratorio quando sono in grado di combaciare con la forma dei recettori (glicani) presenti sulle membrane cellulari. I recettori tipici delle cellule dell’apparato respiratorio umano sono conosciuti come recettori alpha 2-6, e si presentano con forme che ricordano quella di un cono e di un ombrello aperto. Per diffondersi nell’organismo, i ricercatori hanno scoperto che il virus dell’influenza aviaria deve forzatamente acquisire la capacità di legarsi con il recettore a forma di ombrello. Leggi tutto “Così l’influenza aviaria del 1918 divenne epidemia”
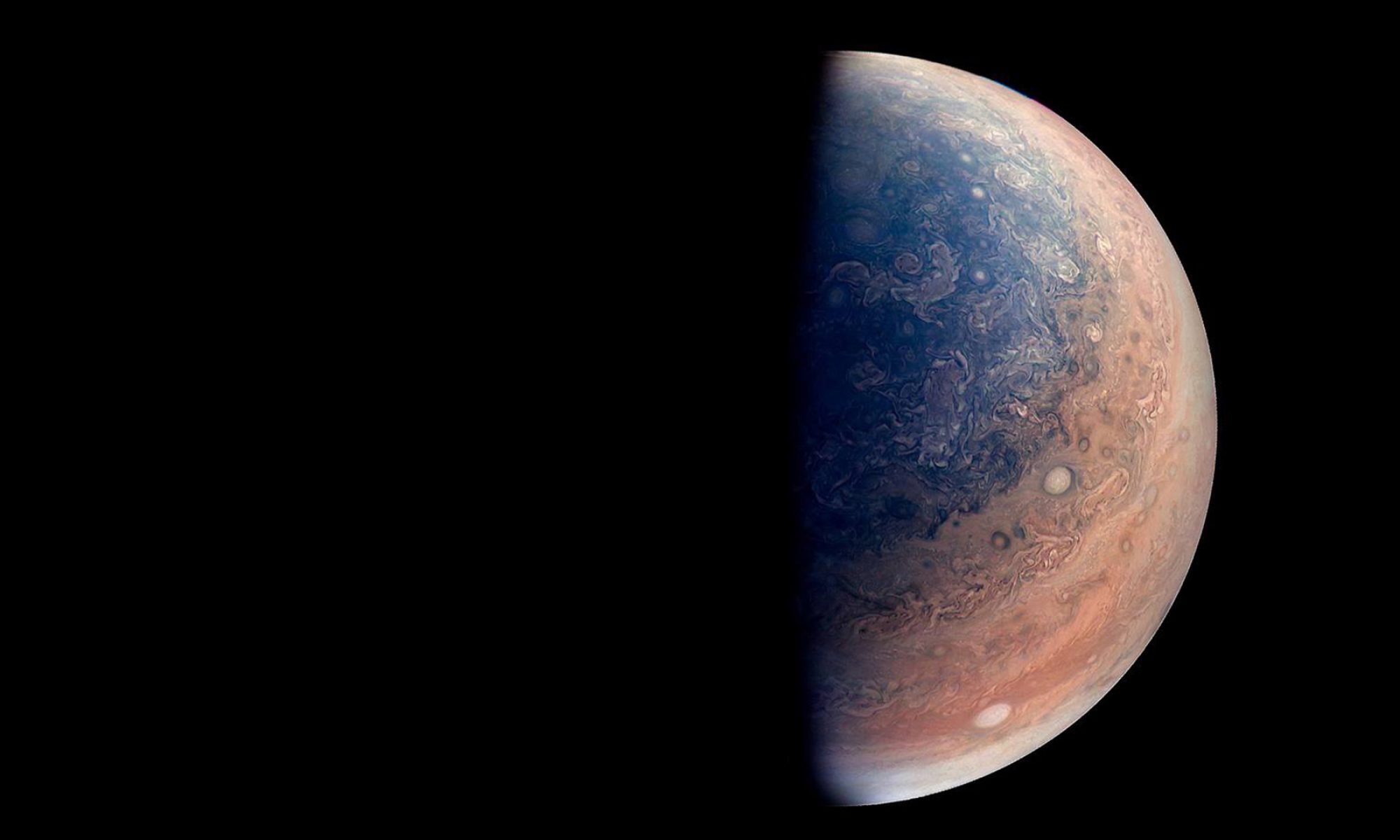
 Prima di questa scoperta, alcune cellule del cervello attivate dal dolore erano già state scoperte, ma erano in grado di offrire informazioni meramente binarie: dolore/non dolore. Ora, il prof.
Prima di questa scoperta, alcune cellule del cervello attivate dal dolore erano già state scoperte, ma erano in grado di offrire informazioni meramente binarie: dolore/non dolore. Ora, il prof.  «Il chip che abbiamo sviluppato consentirà di condurre esperimenti sulle cellule nervose in maniera molto più semplice e rapida» ha dichiarato Andre Levchenko, docente di ingegneria biomedica all’
«Il chip che abbiamo sviluppato consentirà di condurre esperimenti sulle cellule nervose in maniera molto più semplice e rapida» ha dichiarato Andre Levchenko, docente di ingegneria biomedica all’ Passa dalle profondità degli oceani la nuova speranza per combattere il cancro. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Dennis Carson dell’
Passa dalle profondità degli oceani la nuova speranza per combattere il cancro. Un team internazionale di ricercatori, guidato da Dennis Carson dell’ Il prof.
Il prof.  L’importante scoperta è stata resa possibile grazie a un nuovo apparato diagnostico, in grado di rilevare i livelli di glucosio (zucchero) nei pazienti lungo l’intero corso della giornata. Un risultato eccezionale per il prof.
L’importante scoperta è stata resa possibile grazie a un nuovo apparato diagnostico, in grado di rilevare i livelli di glucosio (zucchero) nei pazienti lungo l’intero corso della giornata. Un risultato eccezionale per il prof.