Studiando alcune funzionalità del nostro sistema immunitario, un gruppo di ricercatori ha scoperto un particolare processo che potrebbe spiegare l’incapacità del nostro organismo nel fornire un’adeguata risposta immunitaria contro le cellule tumorali. Questa scoperta potrebbe portare un giorno a una nuova generazione di farmaci per la cura dei tumori.
![Linfocita T [credit: lbl.gov]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/11/t-cell.thumbnail.jpg?resize=99%2C76) In circostanze normali, il sistema immunitario circonda un agente patogeno o una ferita con una impenetrabile infiammazione, in grado di contenere la diffusione dell’infezione e combattere ciò che l’ha causata. Tuttavia, nel caso dei tumori, alcuni meccanismi cellulari contrastano l’insorgenza di uno stato infiammatorio, rendendo il tumore poco identificabile e molto difficile da estirpare con le semplici difese del nostro organismo.
In circostanze normali, il sistema immunitario circonda un agente patogeno o una ferita con una impenetrabile infiammazione, in grado di contenere la diffusione dell’infezione e combattere ciò che l’ha causata. Tuttavia, nel caso dei tumori, alcuni meccanismi cellulari contrastano l’insorgenza di uno stato infiammatorio, rendendo il tumore poco identificabile e molto difficile da estirpare con le semplici difese del nostro organismo.
Studiando le reazioni immunitarie, un gruppo di ricercatori del King’s College (Londra) è riuscito ad approfondire il ruolo di un particolare tipo di “cellule T” (linfociti) in grado di contrastare la fondamentale funzione dei macrofagi, cellule altamente specializzate in grado di inglobare nel loro citoplasma microorganismi e particelle estranee distruggendole. I ricercatori hanno così scoperto che le cellule T funzionano come una manopola per regolare il volume di una radio: questi linfociti regolano la risposta immunitaria dei macrofagi limitando la loro “aggressività” cieca, che li porterebbe a disgregare indistintamente qualsiasi antigene (sostanza estranea) presente nel nostro organismo.
![Macrofago allunga la propria struttura per inglobare due possibili agenti patogeni [credit: Wikipedia EN]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/11/macrofago.thumbnail.jpg?resize=100%2C81) «Un segnale sufficientemente doloroso, come un piccolo taglietto sulla pelle, viene trattato automaticamente dal nostro organismo stimolando la produzione di macrofagi e quindi di uno stato infiammatorio. Abbiamo scoperto che le cellule T svolgono una funzione regolatrice per moderare la reazione dei macrofagi e sono in grado di arrestarne l’azione nel caso di falsi allarmi. Ciò aiuta il sistema immunitario a mantenersi stabile e a prevenire reazioni spropositate agli stimoli cui siamo ogni giorno sottoposti.» ha dichiarato entusiasta il prof. Leonie Taam. Sfortunatamente, le cellule T non riescono sempre a gestire al meglio la loro funzione regolatrice sui macrofagi. Spesso questi linfociti forniscono un’informazione errata al sistema immunitario, che quindi non riesce a rilevare la presenza di cellule tumorali.
«Un segnale sufficientemente doloroso, come un piccolo taglietto sulla pelle, viene trattato automaticamente dal nostro organismo stimolando la produzione di macrofagi e quindi di uno stato infiammatorio. Abbiamo scoperto che le cellule T svolgono una funzione regolatrice per moderare la reazione dei macrofagi e sono in grado di arrestarne l’azione nel caso di falsi allarmi. Ciò aiuta il sistema immunitario a mantenersi stabile e a prevenire reazioni spropositate agli stimoli cui siamo ogni giorno sottoposti.» ha dichiarato entusiasta il prof. Leonie Taam. Sfortunatamente, le cellule T non riescono sempre a gestire al meglio la loro funzione regolatrice sui macrofagi. Spesso questi linfociti forniscono un’informazione errata al sistema immunitario, che quindi non riesce a rilevare la presenza di cellule tumorali.
Approfondendo i loro studi sul particolare rapporto tra cellule T e macrofagi, i ricercatori del King’s College mirano alla creazione di nuovi trattamenti farmacologici per combattere il cancro. La loro scoperta potrebbe portare, inoltre, a una cura per alcune patologie che causano infiammazioni croniche come l’artrite reumatoide.
La ricerca su questa nuova peculiarità del nostro sistema immunitario è ancora agli albori, ma la strada intrapresa appare già molto promettente.
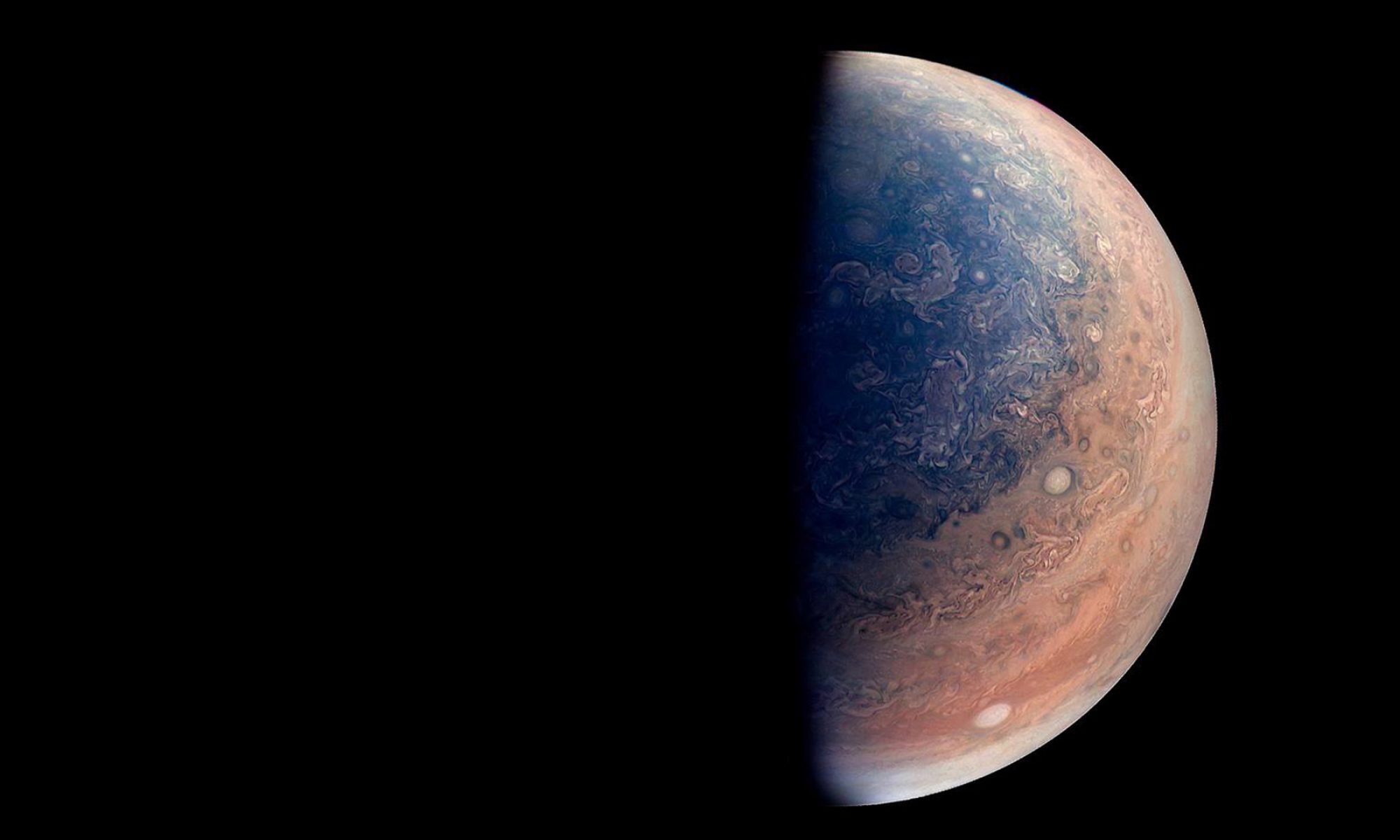


 Dopo numerose ricerche, un team di genetisti è riuscito ad approfondire sensibilmente le conoscenze legate a FTO, il gene ritenuto responsabile dell’obesità, scoperto lo scorso aprile da un gruppo di ricerca britannico. La scoperta potrà aiutare a comprendere meglio come alcune persone tendano ad accumulare grasso più facilmente rispetto ad altre.
Dopo numerose ricerche, un team di genetisti è riuscito ad approfondire sensibilmente le conoscenze legate a FTO, il gene ritenuto responsabile dell’obesità, scoperto lo scorso aprile da un gruppo di ricerca britannico. La scoperta potrà aiutare a comprendere meglio come alcune persone tendano ad accumulare grasso più facilmente rispetto ad altre.![Struttura chimica di base della vitamina D [credit: Wikipedia EN]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/11/vitaminad.thumbnail.jpg?resize=108%2C82)
 Analizzando i telemori, le porzioni terminali delle lunghe catene di DNA, il team di ricerca ha potuto stabilire con precisione l’età biologica delle otre duemila volontarie. Con il passere degli anni, i telomeri divengono progressivamente più corti e la catena di DNA maggiormente instabile, analizzando questi parametri è dunque possibile stabilire l’età biologica di una persona, che può differire anche di molto da quella anagrafica.
Analizzando i telemori, le porzioni terminali delle lunghe catene di DNA, il team di ricerca ha potuto stabilire con precisione l’età biologica delle otre duemila volontarie. Con il passere degli anni, i telomeri divengono progressivamente più corti e la catena di DNA maggiormente instabile, analizzando questi parametri è dunque possibile stabilire l’età biologica di una persona, che può differire anche di molto da quella anagrafica. L’idea per questo esperimento, sicuramente fuori dal comune, è venuta in mente al prof.
L’idea per questo esperimento, sicuramente fuori dal comune, è venuta in mente al prof.  Approfondendo i risultati della ricerca, il team guidato da Mogil ha scoperto che – nei soli topi maschi presentati a Paris – era drasticamente rallentata l’attività del gene c-fos, responsabile della trasmissione dei segnali dolorosi dal midollo spinale al cervello, chiaro indice di una ridotta attività neuronale legata ai centri del dolore.
Approfondendo i risultati della ricerca, il team guidato da Mogil ha scoperto che – nei soli topi maschi presentati a Paris – era drasticamente rallentata l’attività del gene c-fos, responsabile della trasmissione dei segnali dolorosi dal midollo spinale al cervello, chiaro indice di una ridotta attività neuronale legata ai centri del dolore.![Rappresentazione schematica dei meccanismi che portano all’insorgenza dell’artrite reumatoide [credit: en.sanofi-aventis.com]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/11/artrite2.thumbnail.jpg?resize=113%2C89)
![L’artrite reumatoide porta alla irrecuperabile deformazione degli arti di chi ne è affetto [credit: pwp.netcabo.pt]](https://i0.wp.com/www.blogalileo.com/wp-content/uploads/2007/11/artrite1.thumbnail.jpg?resize=93%2C67)